Coxoartrosi

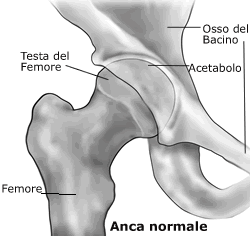
Generalità
E’ una delle più frequenti cause di dolore dell’anca.
La malattia determina:
– inizialmente un assottigliamento “per consumo” della cartilagine articolare (è il rivestimento delle superfici articolari che ha la funzione di facilitare lo scorrimento delle superfici stesse tra loro).
– formazione di osteofiti (becchi ossei) al margine dell’articolazione
– deformazione dell’articolazione nel suo insieme
– quando la cartilagine è completamente usurata le due superfici articolari si trovano direttamente a contatto tra loro, rendendo molto doloroso il movimento.
Cause
– familiarità: c’è maggior probabilità di sviluppare la malattia se ci sono altri membri della famiglia che hanno sofferto della malattia.
– obesità
– età avanzata
– sovraccarico prolungato dell’articolazione (attività lavorativa pesante)
Sintomi
– inizialmente può essere avvertita solo rigidità all’inguine, alla coscia e alla natica ai primi movimenti del mattino.
– in una fase successiva il dolore è spesso avvertito secondo un andamento a 3 fasi: è evidente al mattino al risveglio, diminuisce gradualmente durante la giornata e ricompare verso sera o in caso di impegno eccessivo dell’articolazione. Il riposo, in questa fase, farà diminuire il dolore quando è presente.
– la malattia può diminuire gradualmente la mobilità dell’anca (in rotazione, flessione ed estensione).
– il dolore e la diminuita attività fisica saranno causa di indebolimento della muscolatura dell’anca (ipotono-ipotrofia), in particolare dei muscoli glutei.
Diagnosi
– la descrizione dei sintomi e la modalità di insorgenza del dolore possono aiutare il vostro medico nella diagnosi.
– la limitazione di alcuni movimenti dell’anca provati dal vostro medico (come la rotazione interna e la flessione-rotazione esterna) saranno spesso indicativi.
– Rx per valutare l’eventuale diminuzione (e la sua entità) dello spazio articolare, la presenza di osteofiti o altre anomalie dell’articolazione.
Trattamento
– riposo (nelle fasi di riacutizzazione)
– farmaci analgesici-antiinfimmatori
– riduzione del peso corporeo (nelle persone sovrappeso)
– fkt: rieducazione funzionale (esercizi specifici sia passivi che attivi) ed eventuale terapia fisica nelle fasi di riacutizzazione (laser Nd-Yag; laser IR di potenza; correnti analgesiche-antiinfiammatorie)
Nelle fasi avanzate della malattia:
– può essere necessario l’utilizzo di un bastone per agevolare la deambulazione.
– la chirurgia protesica (artroprotesi d’anca) quando il dolore e la mancata funzione non sono altrimenti eliminabili.
Artriti infiammatorie dell’anca
Generalità
vengono comprese in questo gruppo quelle forme di infiammazione articolare facenti parte di una malattia sistemica (non è considerata in questo gruppo invece la fase infiammatoria acuta di una malattia artrosica dell’anca).
Le più frequenti artriti infiammatorie dell’anca sono:
– l’artrite reumatoide: è una malattia sistemica (che interessa più organi) del sistema immunitario. Sono colpiti solitamente entrambi i lati: anca destra e sinistra, mano destra e sinistra ecc.
– la spondilite anchilosante: è una malattia cronica che interessa con maggior frequenza l’articolazione sacro-iliaca (tra osso sacro e osso pelvico), la colonna vertebrale dorsale e lombare e le articolazioni coxo-femorali (articolazioni dell’anca).
– il l.e.s. (lupus eritematoso sistemico): è una malattia auto-immunitaria sistemica (dovuta al mancato riconoscimento e conseguente aggressione delle proprie cellule) con interessamento di numerosi organi e tessuti.
Sintomi
– dolore localizzato all’inguine e coscia, soprattutto ai primi movimenti del mattino o dopo un’attività più impegnativa.
– rigidità articolare e, nei casi acuti, limitazione funzionale.
Diagnosi
– il vostro medico accerterà quali sono i movimenti limitati o dolenti, se c’è dolore in entrambe le anche o meno, se sono contemporaneamente interessate altre articolazioni.
– Rx per valutare lo stato dell’articolazione (riduzione dello spazio articolare, segni di degenerazione dell’articolazione ecc.)
– esami reumatologici ematici (prelievo di sangue): emocromo, ves, pcr, Waaler-Rose, rheuma-test, ecc.
Terapia
– i farmaci cortisonici sono dei forti antiinfiammatori spesso utilizzati come terapia “di fondo” per modificare l’evoluzione della malattia.
– anche altri farmaci possono rallentare l’evoluzione della malattia (come il metotrexate o la sulfasalazina) prescritti e monitorati nel tempo dal medico specialista (reumatologo).
– la fkt può essere necessaria per mantenere un buon tono muscolare e un “range” di movimento più ampio possibile: la rieducazione funzionale, per questo scopo, è solitamente effettuata lontano dalle fasi di riacutizzazione della malattia.
– la chirurgia ortopedica è utilizzata nelle fasi più avanzate della malattia, quando il dolore e l’inabilità non sono più controllate con la terapia medica e fisioterapica.
Osteonecrosi dell’anca
Generalità
E’ una malattia invalidante che si manifesta spesso, inizialmente, in modo subdolo.
E’ dovuta ad un’ostruzione, locale, dei vasi sanguigni che riducono gradualmente la nutrizione alla testa femorale (parte sferica superiore del femore che si articola con l’osso del bacino).
Senza vascolarizzazione la testa del femore và incontro a necrosi (morte), si frammenta e cede sotto la pressione del peso corporeo.
Conseguentemente anche la cartilagine soprastante degenera. L’incongruenza articolare che ne deriva, porta poi rapidamente ad una artrosi deformante.
Cause
Non è accertata la causa della malattia (ad eccezione di quella post-traumatica).
Se tuttavia sono presenti alcuni dei fattori di rischio qui sotto elencati, in presenza di dolore all’anca (dolore inguinale, gluteo o alla regione laterale dell’anca), sarà necessaria una visita dal vostro medico (fisiatra od ortopedico) di fiducia.
– esiti di frattura o lussazione dell’anca
– età tra 20-50 anni
– alcolismo
– uso di farmaci cortisonici
– artrite reumatoide, LES (lupus eritematoso sistemico)
– malattia di Crohn
– pancreatite cronica
– anemia falciforme
– malattia di Gaucher
Diagnosi
– visita specialistica per valutare la funzionalità dell’anca (il movimento) e la dolorabilità a questa connessa.
– Rx e RMN per valutare variazioni patologiche delle strutture ossee.
Trattamento
– se non c’è già stato un crollo della testa femorale, può essere eseguita una decompressione ed un innesto osseo per facilitare la formazione di nuovi vasi sanguigni e cellule ossee.
– Se c’è già stato un crollo della struttura ossea sarà necessario un innesto protesico (vedi artroprotesi).
Lussazione dell’anca
Generalità
l’articolazione dell’anca è costituita dalla testa del femore (la parte sferica superiore della testa femorale) e dall’acetabolo (parte a cupola dell’osso del bacino) che la accoglie e ne guida il movimento permettendo al tempo stesso una buona stabilità.
Per determinare una lussazione dell’anca (fuoriuscita della testa femorale dal suo alloggiamento) è necessario un trauma di forte intensità.
La lussazione dell’anca è una condizione molto rara negli anziani in quanto la stessa forza traumatica in essi provoca più facilmente una frattura del femore o del collo femorale.
Cause
la causa più frequente è l’incidente automobilistico, ma responsabili possono essere anche gli infortuni sul lavoro o la caduta da una scala.
Spesso sono associate altre lesioni (frattura del bacino, degli arti inferiori, della colonna vertebrale).
La lussazione più frequente è quella posteriore (la testa del femore scivola posteriormente rispetto al bacino).
Diagnosi
la lussazione dell’anca è una condizione molto dolorosa: il paziente non può spostare la gamba e qualora ci siano contemporanee lesioni delle strutture nervose, mancherà la sensibilità alla caviglia e al piede.
Nel caso di lussazione posteriore l’anca è fissa, flessa e ruotata all’interno (nella lussazione anteriore, più rara, l’anca sarà ruotata in fuori).
La lussazione dell’anca è un’emergenza ortopedica.
Il paziente non va spostato: va mantenuto al caldo con una coperta e sarà chiamato immediatamente il servizio medico di soccorso.
– il medico solitamente pone la diagnosi osservando la posizione delle gambe
– la Rx indica la presenza di eventuali fratture associate
Terapia
– se non ci sono fratture il medico esegue, previa anestesia, la riduzione incruenta dell’anca (mediante delle manovre di trazione, flessione e rotazione dell’arto).
– verrà eseguita successivamente una nuova Rx o una TAC (tomografia assiale computerizzata) per accertarsi del corretto posizionamento dell’’nca.
– il chirurgo ortopedico può ritenere necessaria l’applicazione di un apparecchio gessato pelvi-podalico per 30-40 giorni, o in alternativa (specie nei pazienti anziani) la trazione dell’arto a letto per 3-4 settimane.
– Segue la rieducazione motoria concedendo probabilmente la deambulazione con stampelle per un periodo che può raggiungere i 6 mesi (per evitare il carico ed una eventuale necrosi ischemica della testa femorale).
– Un eventuale danneggiamento della cartilagine articolare nel corso dell’evento traumatico, può causare una precoce insorgenza di malattia artrosica dell’anca.
Frattura dell’anca
Generalità
è una lesione traumatica dell’osso femorale nella sua parte superiore (frattura della testa o del collo femorale), molto frequente nell’anziano.
L’osteoporosi post-menopausale e l’età senile (in entrambi i sessi) sono i principali fattori predisponenenti. Più del 90 % delle ospedalizzazioni per frattura dell’anca riguarda persone con più di 65 anni, con una netta prevalenza nel sesso femminile (le donne hanno 1 probabilità su 7 di avere una frattura dell’anca nel corso della loro vita, mentre gli uomini hanno 1 probabilità su 17).
In presenza di osteoporosi la frattura dell’anca può avvenire anche per traumi di scarsa entità come banali cadute durante il cammino.
Le fratture dell’anca hanno spesso una prognosi seria, specie in relazione all’età avanzata di questi pazienti.
Alle fratture legate con la malattia osteoporotica vanno aggiunte quelle legate ai traumi stradali e ad altri incidenti.
Fattori predisponenti
– età: la frequenza aumenta progressivamente dopo i 65 anni
– sesso femminile: le donne hanno 2-3 volte più probabilità degli uomini di fratturarsi l’anca
– ereditarietà e costituzione: sono più frequenti in chi ha avuto un parente che in età anziana ha subito questo tipo di frattura nonchè nei soggetti magri e di costituzione esile.
– una dieta povera di calcio, l’assunzione eccessiva di alcool e l’abitudine al fumo sono fattori predisponenti alle fratture dell’anca
– deficit fisici: equilibrio instabile, debolezza, artrosi-artrite con difficoltà o dolore alla deambulazione, deficit visivo, malattie neurologiche (come il morbo di Parkinson o la Sclerosi a placche)
– deficit mentali: senilità, depressione, demenza (ad esempio malattia di Alzheimer) o deficit psico-sensoriali derivanti dall’uso di farmaci
Prevenzione delle cadute
– può risultare utile in questo senso sottoporsi annualmente ad una visita fisiatrica per valutare le
proprie condizioni fisiche ed eliminare eventuali difficoltà di deambulazione, limitazioni o algie
articolari, deficit di equilibrio.
– il vostro fisiatra od ortopedico vi consiglierà periodici controlli della densità ossea (densitometria
ossea o MOC) – vedi ambulatorio osteoporosi –
– ugualmente utile un periodico controllo della vista, cardiologico e della pressione arteriosa.
– mantenere una buona efficenza fisica attraverso la frequentazione di corsi di ginnastica “dedicata” (con esercizi per mantenere agilità, coordinazione, equilibrio e resistenza) ma anche una assidua attività fisica all’aria aperta e in acqua (piscina).
– eliminare tutti i rischi di caduta in casa e all’esterno (ad esempio eliminare i tappeti o usare le apposite reti antisdrucciolo al di sotto degli stessi, eliminare l’uso di scarpe con tacco alto, eliminare l’uso delle pattine o usare esclusivamente quelle con suola antisdrucciolo, preferire l’uso della doccia con gli appositi sostegni anzichè della vasca da bagno e usare delle stuoie antisdrucciolo per l’uscita , installare corrimani e altri dispositivi di sicurezza, mantenere una buona illuminazione nelle stanze, corridoi e scale, non lasciare cavi elettrici del telefono od altro liberi nel pavimento, ecc.).
– seguire una dieta con adeguato apporto di calcio, evitare un uso eccessivo di alcool e il fumo
Sintomi
il paziente avverte un dolore molto forte localizzato soprattutto all’inguine e non è in grado di alzarsi da terra. Ogni più piccolo movimento causa vivo dolore.
Dovrà essere chiamato al più presto il servizio medico d’urgenza. L’infortunato sarà portato al pronto soccorso dove nella maggior parte dei casi verrà disposto il ricovero e un eventuale intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura o di protesi articolare.
Diagnosi
– generalmente l’arto fratturato appare ruotato all’esterno, avvicinato all’arto controlaterale e accorciato.
– La Rx conferma la diagnosi e dà una indicazione precisa della sede della frattura e degli eventuali spostamenti dei monconi di frattura.
Le fratture dell’anca possono essere divise, per semplificazione, in due gruppi (seppure con molte varianti al loro interno):
1) fratture del collo femorale
2) fratture trocanteriche
Tali fratture differiscono tra loro, oltre ovviamente che per il punto in cui si verifica la lesione, anche per il tipo di trattamento necessario e le relative complicanze.
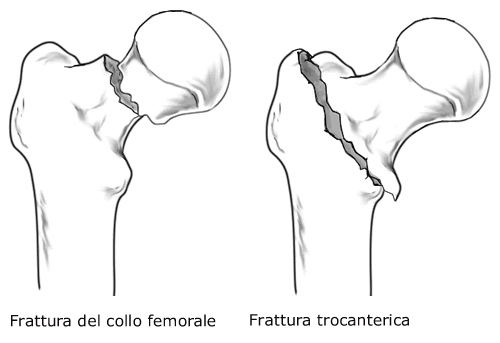
Trattamento
Il trattamento delle fratture dell’anca varierà sia in relazione al tipo di frattura, sia in base all’età del paziente.
– fratture del collo femorale: è generalmente eseguito (nelle persone più giovani) un intervento di osteosintesi usando un “chiodo” o una “vite” fatti penetrare dalla superficie esterna del trocantere femorale fino al centro della testa femorale stessa.

Il paziente potrà muovere l’arto a letto dopo pochi giorni dall’intervento mentre la deambulazione , una volta applicato un gesso pelvi-malleolare, sarà permessa generalmente dopo 3-4 settimane utilizzando delle stampelle per evitare il carico sull’arto colpito. Tale tipo di deambulazione sarà protratta per un periodo che può arrivare ai 4-6 mesi.
Nelle persone di età più avanzata (generalmente oltre i 70 anni) è preferibile un intervento di sostituzione della testa femorale con una endoprotesi metallica (il cui gambo viene infisso nel canale midollare del femore) o con la sostituzione sia della testa femorale che del suo acetabolo (la parte dell’osso del bacino con cui la testa femorale si articola) realizzando una artroprotesi.

Con questo tipo di intervento è possibile muovere liberamente l’arto da subito ed iniziare la deambulazione senza apparecchio gessato già dopo pochi giorni. Ciò riduce in grande misura le complicazioni sia di carattere generale che locale cui andrebbe incontro questa categoria di persone (tromboflebite, embolia polmonare, piaghe da decubito ecc.).
L’uso di un “girello”, di stampelle o di un altro aiuto potrà essere necessario nelle fasi iniziali della deambulazione così come delle terapie di rieducazione funzionale (mobilizzazione, rinforzo muscolare, esercizi di equilibrio e training del passo).
– fratture trocanteriche: sono ancora più frequenti delle precedenti, causate generalmente da una caduta sul fianco, anch’esse interessanti l’anziano (72 anni è l’età media) e il sesso femminile (in una percentuale superiore al 70%).
La prognosi è decisamente migliore rispetto alle fratture del collo femorale.
Nei giovani e negli adulti il trattamento è di solito incruento (immobilizzazione in apparecchio gessato pelvi-podalico per circa 30 giorni; deambulazione con stampelle già dopo pochi giorni).
Nelle persone anziane, allo scopo di ridurre l’immobilità derivante dall’apparecchio gessato e quindi i rischi delle complicanze a questa connessi, si interviene chirurgicamente fissando i due segmenti ossei per mezzo di viti-placca, chiodi-placca o ancor più semplicemente con dei chiodi endomidollari.


La stabilità della frattura data da tali mezzi di sintesi permette una deambulazione precoce con la possibilità di caricare già nei primissimi giorni.



